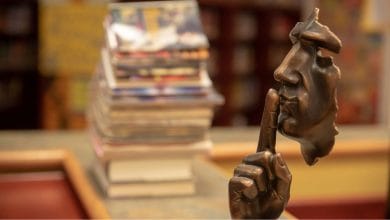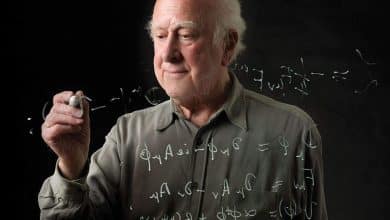Viviamo immersi nei social, bombardati da post e trend assurdi, reel, e chi ne ha più ne metta. Alcuni di questi sembrano creati apposta per dividere, far discutere e infiammare i commenti. Ma perché? Da dove nasce questo bisogno quasi compulsivo di pubblicare provocazioni sempre più spinte sui social? Il fenomeno è più profondo di quanto sembri. E non lo diciamo noi de Il Bosone: ci sono teorie sociologiche che aiutano a mettere a fuoco quello che accade dietro lo schermo.
Contenuti estremi sui social media: perché attirano così tanto?
Nell’era digitale, tutto ruota attorno a una sola moneta: l’attenzione, che continua a diminuire a causa dei modelli AI, aumentando la nostra pigrizia. È su questa logica che si fonda una parte consistente del successo dei contenuti estremi sui social media. Non importa se piacciono o indignano: l’importante è che se ne parli, si commenti, si condivida. Ma questa è solo la superficie.
Nei social media, vince chi urla più forte. I contenuti provocatori vengono premiati con visibilità perché generano interazioni. Lo sa bene chi produce contenuti virali: indignazione, stupore e shock sono potenti calamite per l’occhio. In un mare di post, il contenuto che scandalizza ha una marcia in più. E non serve neppure che sia autentico: l’effetto viene prima della verità.
Guy Debord, con la sua idea di “società dello spettacolo”, aveva già intuito tutto: viviamo in un mondo dove conta più l’apparenza che la sostanza. Lo spettacolo è diventato il nuovo linguaggio sociale, e ogni post estremo è una performance.

I feed dei social non sono neutri. Gli algoritmi premiano ciò che tiene incollati allo schermo, e spesso questo coincide con contenuti polarizzanti. Più un post divide, più finisce in alto. In pratica, le piattaforme non solo ospitano contenuti estremi, ma li spingono attivamente.
Ci sarebbe da fare una parentesi sul linguaggio dei politici in tal senso, ma non è questo il luogo.
Insomma, non è un errore del sistema: è il sistema stesso che funziona così.
Con milioni di utenti in competizione per un attimo di attenzione, distinguersi è diventata una necessità. Da qui nasce la corsa alla provocazione. Ogni post estremo è una candidatura per essere notati, seguiti o anche solo per finire su qualche screenshot virale. E quando l’approvazione sociale diventa misura del proprio valore, l’esagerazione è solo un mezzo tra tanti.
Come siamo arrivati a questo? Un tempo, giornali e TV avevano redazioni, direttori, filtri editoriali. Oggi basta uno smartphone per pubblicare qualsiasi cosa, e il pubblico è spesso più veloce dei controlli. I contenuti estremi sui social media si diffondono prima che qualcuno possa verificarli, e quando arrivano le smentite, è già troppo tardi: l’impatto è fatto, il polverone sollevato.
Brb gotta go get my stomach pumped 🤪♬ original sound – Avery Cyrus
Basti pensare alla quantità di fake news che ci sommergono, alle cui spalle c’è un meccanismo psicologico ben preciso. A tal proposito Jean Baudrillard ci porta nel territorio dell’iperrealtà, dove i confini tra vero e falso si dissolvono. I contenuti estremi diventano simulacri: copie senza originale, creati solo per esistere e alimentare altra finzione.
C’è infine da analizzare la parola stessa: “social”. I quanto tali, questi creano micro-comunità in cui l’estremo diventa segnale di appartenenza. Più un contenuto è divisivo, più rafforza il gruppo. Chi pubblica provocazioni spesso non cerca il dialogo, ma l’approvazione di una nicchia che condivide lo stesso codice. E più quel codice è estremo, più il gruppo si sente “unito contro il resto del mondo”.
Zygmunt Bauman, in tal senso, parlava di “modernità liquida”: identità sempre più instabili, che cercano validazione in ogni angolo digitale. La provocazione diventa un modo per affermarsi, anche solo per un momento.
Il punto non è solo chiedersi “Perché i content creator lo fanno?”, ma anche “Perché funziona così bene su di noi?”. In fondo, forse, ciò che ci disturba è che guardando quei contenuti…vediamo anche qualcosa di noi.