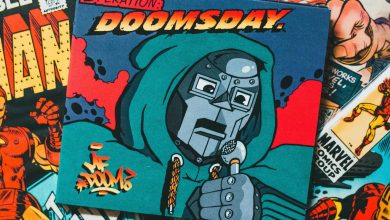Per decenni si è dato quasi per scontato che l’Unico Anello di Tolkien derivasse dall’epopea dei Nibelunghi. Un’idea suggestiva, carica di mitologia, ma che lo stesso autore smentì con decisione. L’origine del più celebre artefatto della Terra di Mezzo, infatti, guarda in tutt’altra direzione.
L’Unico Anello di Tolkien si ispira all’anello di Gige e non ai Nibelunghi
Il primo a proporre l’associazione fu lo studioso svedese Åke Ohlmarks, e da lì la tesi ha preso piede fino a diventare quasi un luogo comune. Eppure, Tolkien nel 1961 rispose in modo ironicamente lapidario (ma in realtà piuttosto furioso) nella lettera n. 229:
“Entrambi gli anelli erano rotondi e lì finisce la somiglianza”.
(potete leggere qui la lettera: https://bibliothecaveneficae.com/wp-content/uploads/2021/01/the_letters_of_j.rrtolkien.pdf?srsltid=AfmBOopS_kJ2XyqxboWxMstdm0sI74ApjaQYkeFD8Rt3JV52f5dySzm5)
Se si osserva il mito germanico, l’anello dei Nibelunghi è un oggetto di dominio e di ricchezza, uno strumento di potere che trascina alla rovina chi lo possiede. Funziona come una maledizione, ma non offre invisibilità né la sottile corruzione interiore che caratterizzano l’Unico. L’analogia, dunque, regge ma solo in superficie.

Insomma, forse si è voluto creare un po’ troppo hype come successo con un ritrovamento archeologico eccezionale.
Per capire la vera ispirazione bisogna guardare a un contesto completamente diverso: la filosofia antica. Ne La Repubblica di Platone, precisamente nel Libro II, 359c–360b, il personaggio di Glaucone racconta la storia di Gige, un pastore che scopre un anello capace di renderlo invisibile.
Una volta compresa la sua proprietà straordinaria, Gige lo usa per sedurre la regina, uccidere il re e impadronirsi del trono. Non è difficile intravedere il parallelo con Smeagol, che uccide il cugino Déagol per impossessarsi dell’Anello.
Il tema non è l’oro, né la ricchezza materiale. È il potere che nasce dall’impunità. L’invisibilità diventa la prova definitiva della tenuta morale di chi la possiede: chi potrebbe resistere alla tentazione di agire senza conseguenze?
Glaucone arriva a una conclusione spietata: se esistessero due anelli, uno al giusto e uno all’ingiusto, nessuno dei due saprebbe resistere alla tentazione. L’idea che la giustizia non sia una virtù intrinseca ma una convenzione sociale riecheggia sorprendentemente nelle parole di Gandalf, Elrond e Frodo, quando affermano che persino i più saggi e bene intenzionati verrebbero corrotti dall’Unico.

Nello specifico nel Libro I, cap. 2, lo stregone dice:
Non posso prendere l’Anello, Elrond. Non posso sopportarlo
E ancora, nel Libro 2, cap. 2, lo stesso Ainur riferisce al Consiglio:
Tutto dipende da come lo si usa, e nessuno, nemmeno i più saggi, può resistere a lungo alla sua influenza
La forza di Tolkien sta nell’aver trasformato questo esperimento mentale in una narrazione viva. Non si limita a ribadire la teoria: la mette alla prova attraverso personaggi concreti, che oscillano tra la tentazione e il rifiuto, tra il desiderio di fare il bene e il rischio di precipitare nel male.
Ovviamente. collocare l’Unico Anello accanto a quello di Gige non significa ridurre la portata del capolavoro tolkieniano, ma anzi comprenderne la profondità di alcuni messaggi. Tolkien attinge a una riflessione millenaria sul potere assoluto e sulla fragilità della volontà umana, intrecciandola con il suo universo mitopoietico.
È qui che l’Anello mostra la sua vera natura: non solo un artefatto magico, ma il punto d’incontro tra letteratura, filosofia e morale.